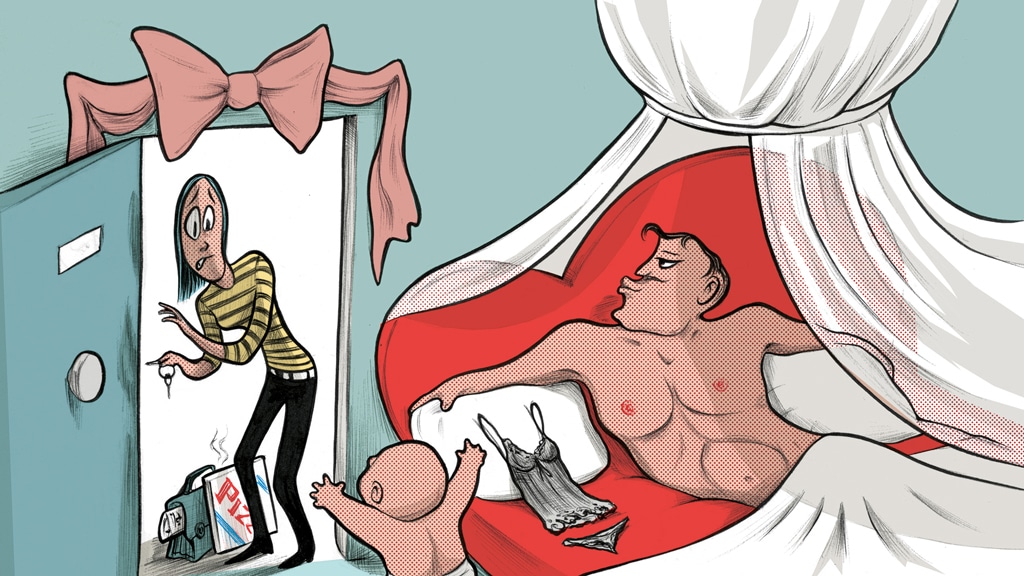Il sommozzatore britannico Chris Lemons si è trovato nella rara situazione di assistere alla propria morte. Quasi tutti i quaranta minuti della scena sono stati registrati in un video, che lui ha visto il giorno dopo a bordo della Bibby Topaz, la nave di 106 metri da cui si immergeva, facendo il tifo per se stesso.
In quelle immagini confuse in bianco e nero, si vede Lemons sdraiato su un fianco sul fondo del mare del Nord, sopra una struttura di tubi di metallo per la trivellazione. La muta e il casco lo fanno somigliare a un astronauta. All’inizio gli arti si contraggono in modo innaturale, le mani si allungano disperatamente nel buio verso il sommergibile telecomandato che la sua nave ha mandato per recuperarlo.
Poi i movimenti si fermano, e l’oscurità del mare incornicia la sua fine solitaria. È a 90 metri di profondità e non può respirare. A causa di un improvviso guasto tecnico, la Bibby Topaz ha cominciato ad allontanarsi da lui proprio nel momento in cui il suo tubo dell’aria si è impigliato nella struttura. Il tubo arrivava alla sua campana subacquea, collegata tramite cavi alla nave, e per un momento Lemons è stato l’unica cosa a tenere ferma la nave da ottomila tonnellate.
Poi il tubo si è rotto.
“È stato come se qualcuno avesse staccato un jack da un altoparlante”, mi ha detto Lemons quando ci siamo sentiti di recente. “Ho perso ogni comunicazione, il che ti fa sentire estremamente solo. E improvvisamente non ho più avuto niente da respirare”.
Passa mezz’ora prima che il problema sia risolto e la nave possa riposizionare la campana per salvare Lemons. Quando il suo corpo privo di sensi è recuperato, e i suoi compagni Dave Yuasa e Duncan Allcock riescono miracolosamente a rianimarlo, Lemons è rimasto senza respirare per tutto il tempo.
Per la maggior parte di noi osservare la propria morte, soprattutto in uno scenario così desolato, potrebbe rivelarsi piuttosto difficile. Ma non per Lemons. “Penso di essere un po’ come tutti gli altri che hanno guardato il video, chiedendosi: ce la farà?”, ha detto.
Lui ce l’ha fatta, ma altri no. Traumatizzati dall’incidente, trasmesso in streaming sui monitor a bordo della Bibby Topaz, alcuni membri dell’equipaggio hanno lasciato il lavoro. Su di lui e sui suoi compagni di immersione, invece, quell’incidente avvenuto nel 2012 a 115 miglia dalla costa di Aberdeen, in Scozia, ha prodotto l’effetto opposto. “In un certo senso, è stato un momento positivo”, ha spiegato, “Ci ha dato più fiducia”. Tre settimane dopo, Lemons e i suoi colleghi erano di nuovo in fondo al mare per terminare l’operazione.
Se non sei un sommozzatore in saturazione, è difficile immaginare questi terrificanti eventi come una giornata normale. Lemons e i suoi colleghi si immergono a profondità comprese tra 90 e 300 metri e rimangono a pressioni fino a 30 volte superiori a quella del livello del mare per un mese intero. Per questo vivono in camere pressurizzate a bordo di navi o piattaforme petrolifere, scendendo dentro campane subacquee fino ai loro luoghi di lavoro sul fondo del mare, il posto più buio, remoto e inospitale che si può trovare sulla Terra. In una situazione del genere, rischi come quelli corsi da Lemons sono quasi la norma.
Perfezionata dal laboratorio di ricerca medica sui sottomarini della marina degli Stati Uniti alla fine degli anni cinquanta, l’immersione in saturazione – chiamata “sat” dagli addetti ai lavori – diventò rapidamente una manna per l’industria petrolifera e portò a una massiccia proliferazione di piattaforme offshore. Entro il 1972 solo nel golfo del Messico il loro numero era passato da poche centinaia a quasi tremila, grazie soprattutto ai sommozzatori sat che potevano costruire le infrastrutture necessarie per le trivellazioni in alto mare. Da allora i numeri hanno continuato a crescere.
“In sostanza, siamo i gloriosi idraulici del sistema”, ha affermato Lemons.
Ma l’idraulica a queste profondità non è solo questione di chiavi inglesi e tubi : è una lotta contro le leggi della fisica e della biologia. Le immersioni in saturazione arrivano al limite di ciò che un corpo umano può sopportare.
Ogni immersione sui fondali è un negoziato con le leggi dei gas e con la fisiologia. Senza le camere sigillate e pressurizzate in cui i sommozzatori vivono per settimane, le speciali miscele di gas che respirano e le campane che li trasportano dalle camere al fondale oceanico, i loro corpi si bloccherebbero, soffocherebbero o si disgregherebbero dall’interno. Chi fa questo lavoro sopravvive solo perché siamo riusciti a stabilire una fragile tregua con le leggi che governano i gas sottoposti a pressione intensa a profondità che gli esseri umani non sono fatti per esplorare.
Una lattina agitata
I nostri corpi tendono ad assorbire gas quando sono sottoposti ad alta pressione. A grande profondità, inalare aria compressa normale spinge i gas inerti, principalmente l’azoto, a entrare nel sangue e nei tessuti. L’aria che respiriamo normalmente è composta per circa il 78 per cento da azoto e per il 21 per cento da ossigeno (con tracce di argon e altri gas). Nella vita di tutti i giorni, il nostro corpo essenzialmente ignora l’azoto. È inerte.
Alla profondità di saturazione, respirare un gas più pesante dell’elio sarebbe come cercare di bere una zuppa con la cannuccia
Ma una volta raggiunti i nove metri di profondità, la pressione su di noi raddoppia rispetto a quella a livello del mare, e i gas si comportano in modo diverso. In una tipica immersione, quando un sommozzatore respira aria normale, l’azoto si infiltra nel sangue e nei tessuti, creando un carico che può esplodere in bolle durante la risalita. Se si risale in superficie troppo velocemente, il corpo diventa essenzialmente una lattina di birra agitata. L’azoto si separa dal sangue e dai tessuti, bloccando la circolazione, depositandosi nelle articolazioni e arrivando a provocare sintomi simili a quelli di un ictus se interrompe l’apporto di ossigeno al cervello. Questo disturbo si chiama malattia da decompressione, e nei casi gravi può portare alla morte.
Le cose peggiorano man mano che si scende in profondità. L’azoto diventa una bomba a orologeria nei tessuti e rende come ubriachi, uno stato noto come narcosi da azoto. Ma respirare una miscela troppo ricca di ossigeno provoca qualcosa di simile a un trip da acido con contorno di convulsioni. Solo quando sono completamente saturi di gas inerte i subacquei sono al sicuro dagli effetti collaterali che la respirazione produce al di sotto dei 90 metri, dove la pressione è 10 volte superiore a quella a cui è sottoposto un corpo al livello del mare.
Prima dell’avvento delle immersioni in saturazione, le persone potevano lavorare solo per circa mezz’ora a non più di 36 metri sotto il livello del mare prima di dover risalire. Più rimanevano in profondità, più azoto si accumulava nel loro organismo, quindi dovevano fare diverse lunghe soste durante la risalita per consentire al gas di dissiparsi lentamente. Questo rendeva difficile qualsiasi lavoro sott’acqua. Immaginate che un falegname salga al quarantesimo piano di un grattacielo a piantare un chiodo, e poi scenda con un ascensore che non arriva a terra fino al mattino successivo.
La saturazione funziona ritardando il processo di decompressione. I sommozzatori entrano in quello che viene chiamato un complesso di saturazione, che si trova a bordo di una nave di supporto per immersioni o di una piattaforma petrolifera. Sono sigillati ermeticamente al suo interno e portati alla pressione della profondità in cui lavoreranno, dove restano fino al termine della missione senza uscire per nessun motivo. Perdersi compleanni, matrimoni, anniversari e funerali fa parte del lavoro. L’isolamento finisce solo quando vengono depressurizzati, un processo che dura diversi giorni.
Le persone che svolgono questo tipo di lavoro sono quasi esclusivamente uomini (si sa di solo quattro donne) di età compresa tra i 25 e i 40 anni. Se fossero più giovani non avrebbero l’esperienza necessaria. Se fossero molto più anziani potrebbero non essere in grado di reggere. Si pensa che siano tra i settemila e i dodicimila in tutto il mondo, forse meno, osserva Jerry Shepherd, istruttore capo della scuola di immersioni del South Louisiana community college, negli Stati Uniti. Solo uno su 15 dei suoi studenti diventa un sommozzatore in saturazione. E sono ancora meno quelli che fanno questo lavoro a lungo: la prima immersione di un mese spesso rivela i più deboli di cuore. Secondo Lemons, per resistere è fondamentale essere attratti dalle caratteristiche e dai rischi del lavoro.
Innanzitutto, una volta ottenuto il diploma e un posto nell’elenco dei sub non c’è un programma fisso. Gran parte del lavoro consiste nell’aspettare una chiamata.
Voci da scoiattolo
All’inizio di giugno, quando ho pranzato a New Orleans con Jeff e Dave, due sommozzatori del golfo del Messico, entrambi non vedevano l’ora di prendersi qualche settimana di ferie. Alla seconda birra, però, erano già stati contattati per un incarico che sarebbe cominciato la mattina successiva. Ma un sommozzatore affermato lavora circa 160 giorni all’anno, e con tutto quel tempo libero, ha detto Shepherd, alcuni possono comportarsi male a terra, dando alla professione una cattiva reputazione. Risse, relazioni burrascose e problemi con la legge sono attività extracurricolari frequenti. Ma tutto questo rimane a terra: l’ambiente claustrofobico delle camere a pressione rende il lavoro più adatto a persone che sanno essere equilibrate e socievoli in servizio. “Gli stronzi tendono a non durare molto in questo settore”, ha aggiunto Shepherd.
Chi esce dalla scuola di Shepherd deve fare anni di immersioni a bassa profondità prima di essere preso in considerazione per la saturazione. Comincerà immergendosi con l’autorespiratore ad aria compressa fino a circa 36 metri, poi passerà a respirare miscele di gas a maggiore profondità e con retribuzioni più elevate. A quel punto, con un po’ di fortuna, il supervisore potrebbe individuarlo per una promozione. Ma la perseveranza paga. I sommozzatori in saturazione guadagnano regolarmente dai 180mila ai 200mila dollari all’anno. “Sono bei soldi per stare seduto in una camera d’acciaio per metà dell’anno”, ha detto Shepherd.
Una camera di saturazione somiglia a un gigantesco tubo per criceti fatto di cilindri metallici. A seconda delle dimensioni della nave di supporto può ospitare da sei a 24 persone. Ognuna dispone di alloggi leggermente meno spaziosi di un pulmino, con le pareti rivestite di cuccette affiancate da una piccola area salotto e un tavolo. È quasi come essere chiusi in una capsula spaziale.
Una volta entrati, i sommozzatori sono pressurizzati per diverse ore fino a raggiungere la pressione a cui lavoreranno una volta scesi in profondità. Allo stesso tempo, l’aria all’interno della camera si trasforma in una miscela di elio e ossigeno, chiamata eliox. Sotto pressione, l’aria che respiriamo in superficie diventa tossica: l’azoto condiziona le funzioni dei neurotrasmettitori nel cervello con effetti anestetici. Anche i livelli di ossigeno devono essere modulati: una quantità eccessiva di gas diventa velenosa e innesca spasmi, allucinazioni e dolori al petto. L’eliox, quindi, non contiene azoto e solo una piccola percentuale di ossigeno per tenere in vita i subacquei. Sotto pressione, anche una piccola dose è sufficiente. L’elio, che è più leggero, è molto facile da respirare. Alla profondità di saturazione, con qualsiasi gas più pesante inspirare sarebbe come cercare di bere una zuppa con la cannuccia.
A causa dell’elio i sommozzatori parlano come un coro di scoiattoli per tutto il tempo. Nella maggior parte delle camere i sistemi di comunicazione sono dotati di decodificatori per rendere più comprensibili le loro voci al personale esterno.
Una volta raggiunta la pressione necessaria per la profondità a cui lavoreranno, è possibile cominciare la discesa. Un gruppo entra nella campana, una struttura d’acciaio a forma di uovo che si stacca dagli alloggi e viene mantenuta alla stessa pressione.
La campana, spaziosa quanto il cubicolo di un bagno pubblico, viene calata con dei cavi fino al fondale, e le sue pareti spesse cinque centimetri proteggono i subacquei dalla pressione. Lemons la chiama il “taxi per il cantiere”, anche se la sua descrizione della discesa scricchiolante e tremolante verso profondità sempre più buie, che può durare fino a un’ora, mi ha fatto pensare a un viaggio in ascensore verso gli abissi. Stipati nella campana insieme ai sommozzatori ci sono i loro ingombranti caschi Kirby Morgan, che loro chiamano “cappelli”. In genere si opera in gruppi di tre per turni di sei ore, con quattro squadre che si alternano, in modo che il lavoro prosegua senza interruzioni.
Appesi a dei ganci, nella campana ci soni i tubi ombelicali arrotolati. Si chiamano così perché trasportano tutto quello che serve ai sommozzatori per lavorare e per restare vivi: l’eliox, l’elettricità e i segnali in fibra ottica per la comunicazione. Ogni casco è dotato di un microfono e di una telecamera che li tengono in contatto con i loro supervisori sulla nave. Date le rigide temperature delle profondità a cui operano, un altro tubo trasporta acqua calda fino ai canali delle mute a tenuta stagna in neoprene.
Quando arrivano sul fondale, i subacquei escono dalla campana attraverso il portello. Poiché la pressione della campana è uguale a quella della profondità a cui lavorano, l’acqua di mare resta fuori. Due subacquei indossano quindi i caschi con l’assistenza del terzo, che rimane nella campana per gestire i cavi ombelicali che si srotolano dietro i sommozzatori. Ognuno di loro può muoversi in un raggio di circa 45 metri.
È a questo punto che la pressione, sia letterale sia metaforica, comincia a farsi sentire, mi ha detto Dave. “A qualche centinaio di metri sopra di te c’è una nave con 160 persone a bordo: cuochi, tecnici di supporto, navigatori, e sono tutti lì per permetterti di stringere quel bullone sul fondo dell’oceano”, ha spiegato. “Non puoi sbagliare.”
Al termine del turno, i subacquei risalgono nella campana fino alla camera pressurizzata sulla nave. La campana è collegata alla camera per mantenere una pressione uniforme. I sommozzatori attraversano quindi una camera stagna per rientrare nel loro bozzolo metallico riempito di elio, ancora isolati dal mondo esterno.
Sala d’attesa
Quando sono andato a trovarlo nella sua scuola di immersioni a Morgan City, in Louisiana, Shepherd mi ha mostrato una serie di tabelle di decompressione con i tempi di attesa per le varie profondità di immersione. In generale, lo standard prevede un giorno di attesa ogni trenta metri di profondità, più un giorno extra, il che significa che una squadra di sommozzatori che ha lavorato a trecento metri di profondità – oltre la quale non si può andare per evitare la sindrome nervosa da alta pressione, caratterizzata da tremori e danni neurologici – deve aspettare undici giorni prima di poter uscire all’aria aperta. Durante questo periodo la pressione viene gradualmente ridotta, con diverse pause per evitare shock. Anche le miscele di gas sono modificate. L’elio viene gradualmente eliminato, i livelli di ossigeno sono regolati per rimanere sicuri, e i sommozzatori si riabituano a respirare l’aria di superficie, mi ha spiegato Shepherd. Sono le ore più lunghe. “In questi momenti capisci che non sei pagato tanto per immergerti, quanto per aspettare dentro un barattolo”, dice Lemons. Di solito queste lunghe ore sono dedicate a leggere libri, vedere film e tenersi in contatto con la famiglia usando qualsiasi connessione internet disponibile. Paul Dinesson, un sommozzatore norvegese, ne ha approfittato per scrivere un’autobiografia in tre volumi di duemila pagine, ancora inedita.
Mentre i sommozzatori sono in immersione, la loro nave di supporto è tenuta ferma da un sistema di posizionamento dinamico: una rete di propulsori guidati da gps che funziona come un’ancora elettronica, mantenendo l’imbarcazione immobile indipendentemente da dove il mare e il vento la spingerebbero. Questi sistemi sono talmente perfezionati che un guasto è quasi impensabile.
Eppure è esattamente quello che è successo la notte della fatale immersione di Lemons. A causa di un guasto al sistema di posizionamento dinamico della Bibby Topaz, la nave è andata alla deriva nella corrente del mare del Nord, trascinando la campana subacquea, Lemons e i suoi compagni attraverso la colonna d’acqua. Poi il tubo ombelicale di Lemons si è impigliato nella struttura di perforazione che stavano ispezionando quel giorno.
Nel 1970 il sommozzatore Donald Boone ebbe un’esperienza estremamente spiacevole sul water della sua camera
“Non ho visto nessuna grande luce”, mi ha detto Lemons. “Quando ho ripreso conoscenza, ero confuso, anche se dalle espressioni sui volti di Dave e Duncan capivo che era successo qualcosa di grave”.
Uno studio sui fattori che hanno salvato Lemons ha evidenziato l’ottimo addestramento degli operatori, la perfetta miscela del gas, che ha permesso ai suoi tessuti di accumulare ossigeno, e la perdita di conoscenza, che ha ridotto i consumi del suo organismo. Ma non sempre si può contare sulla coincidenza di tutti questi elementi quando qualcosa va storto.
Gli incidenti più gravi nella storia delle immersioni in saturazione sono stati causati dalle differenze di pressione tra le camere di immersione e l’ambiente a livello del mare. Anche se l’esperienza di Lemons ha portato a diversi miglioramenti nella sicurezza, gli incidenti succedono comunque.
I più drammatici tendono a mettere in luce il conflitto tra il nostro corpo, fatto per vivere più o meno al livello del mare, e le leggi della fisica che governano i gas che respiriamo quando sono sottoposti a 30 atmosfere di pressione.
Quanto può essere potente questo conflitto è stato dimostrato nel 1970, quando un sommozzatore del golfo di nome Donald Boone ebbe un’esperienza estremamente spiacevole sul water della sua camera. A quei tempi, agli esordi delle immersioni in saturazione, i water funzionavano come semplici camere di compensazione: una valvola interna al water veniva aperta per scaricare i rifiuti, e poi richiusa. All’esterno si apriva un’altra valvola per aspirare il contenuto in un serbatoio mantenuto alla pressione della superficie. Nel caso di Boone, entrambe le valvole si aprirono per errore contemporaneamente mentre lui era ancora seduto sul water. Di conseguenza, il suo intestino tenue e quello crasso furono risucchiati fuori dal corpo mentre l’aria ad alta pressione all’interno della camera si riversava all’esterno.
Boone sopravvisse, ma fu necessaria una procedura piuttosto complessa. Due chirurghi traumatologici furono condotti in elicottero fino alla sua nave, poi furono portati alla pressione di Boone in una camera iperbarica. Usando solo anestesia locale perché la pressione rendeva impossibile l’uso dei normali anestetici gassosi, operarono Boone all’interno del complesso iperbarico, stabilizzandolo abbastanza da sopportare diversi giorni di decompressione per poi procedere a un altro intervento più completo a terra. Da allora i bagni delle camere pressurizzate hanno valvole supplementari per evitare che quest’orrore si ripeta.
Qualcosa di ancora più grave successe nel 1983 a bordo di una piattaforma di perforazione norvegese del mare del Nord chiamata Byford Dolphin, dove un normale trasferimento di subacquei dalla campana alle camere di decompressione andò terribilmente storto. Un morsetto che fissava la campana alla camera si aprì troppo presto, esponendo immediatamente i sommozzatori a una decompressione esplosiva. In un batter d’occhio, la camera passò dalla pressione di profondità a quella del livello del mare come una lattina di birra agitata. La differenza di pressione fu così forte che uno di loro fu fatto letteralmente a pezzi. Altri tre morirono all’istante a causa dello scoppio delle bolle di azoto nel loro sangue e nei tessuti. Una quinta persona, un assistente esterno, fu colpita e uccisa dalla campana scagliata via dalla camera come una palla di cannone.
Paura delle mante
Episodi meno drammatici, ma comunque terrificanti, fanno parte della storia personale di ogni subacqueo. Shepherd mi ha parlato della sua paura delle mante, che giacciono mimetizzate sul fondale e che, se spaventate, schizzano verso superficie. Quando succede, il tubo ombelicale può rimanere incastrato nelle appendici carnose intorno alla bocca della manta, trascinando il subacqueo verso una decompressione inaspettata e potenzialmente fatale. Dinesson è stato quasi risucchiato sotto il palo di una piattaforma petrolifera che veniva riposizionata.
Allora perché mai qualcuno dovrebbe continuare a fare questo lavoro, ho chiesto a Lemons. “Ci si abitua a considerare normale qualunque cosa”, mi ha risposto.
Lemons, che ha 45 anni, oggi lavora in superficie come supervisore subacqueo, ma per motivi che non hanno a che fare con il suo incidente, dopo il quale ha continuato a immergersi in saturazione per altri dieci anni. La sua esperienza è stata raccontata in un documentario prodotto da Netflix e dalla Bbc intitolato Last breath e in un film dallo stesso titolo. Lemons si è preso un anno sabbatico per presentare il film, ma ha in programma di tornare al lavoro.
La sua perseveranza, mi ha detto, potrebbe avere a che fare con il suo nuovo rapporto con la propria mortalità. Mentre giaceva sul fondo del mare del Nord, il panico era stato sostituito da qualcosa di completamente diverso. “Ricordo ancora come ho sentito la paura svanire”, mi ha detto. “Avevo fatto tutto il possibile, e ho pensato piuttosto tranquillamente: be’, eccoci qua. Se è così che dovrò andarmene quando arriverà il mio momento, non è poi così male”. ◆ bt
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1641 di Internazionale, a pagina 62. Compra questo numero | Abbonati